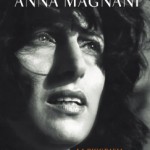 L’uscita della biografia su Anna Magnani (edita da Bompiani, 400 pagine, 19 euro) scritta da Matilde Hochkofler con la collaborazione di Luca Magnani (figlio dell’attrice) rappresenta un evento per rimarcare l’immenso e immortale talento di un temperamento interpretativo che sempre costituirà un vanto della nostra cultura cinematografica. La Hochkofler è dedita da anni al cinema italiano e della Magnani ha già scritto più volte (Anna Magnani Lo spettacolo della vita del 2005 per Bulzoni editore; Anna Magnani, sempre del 2005, per Gremese editore) occupandosi nel 2004 della mostra fotografica Ciao Anna ai musei Capitolini di Roma. Il contributo inedito di Luca Magnani resta fondamentale per la stesura del testo. Una collaborazione offerta per via dell’impegno che l’autrice ha dedicato nel corso degli anni all’interprete romana. La Hochkofler presenta in maniera minuziosa e descrittiva le vicissitudini della Magnani; l’eterno e costante bisogno d’amore, l’indole contraddittoria nella sua fragilità ma densa di una forte e distintiva personalità, la lesione forse mai colmata inerente all’allontanamento della madre, la lealtà e le intemperanze di un carattere in qualche modo bisognoso, e coerente verso l’arte e il pubblico. La testimonianza di Luca è una chiave di svolta fresca nel raccontare la vita della madre ma soprattutto il loro complicato rapporto, apparentemente distaccato e denso di contrasti, ma che in un futuro “adulto” si definirà come forte collante caratterizzato da profondo affetto. L’autrice dunque articola un testo su due binari paralleli per ricordare, con equilibrio, vita privata e artistica di un personaggio intramontabile tuttora presente nell’attuale. Non importa se della Magnani (classe 1908) si è detto e scritto di tutto perché di fronte a una personalità così espansa non resta che arrendersi. Tuttora, infatti, può servire ad esempio per essere punto di riferimento di tutte quelle giovani attrici che aspirano a oltrepassare la linea dell’approssimazione recitativa. Nazional popolare e internazionale grazie a una presenza scenica che si mescola con sfaccettature rurali e raffinate, l’interprete romana disegna durante l’arco di tutta la sua carriera ruoli che riflettono uno schema ben disegnato attraverso virtuosismi recitativi che rimandano a quelli cantati dalla Callas dei tempi migliori. Tutto appare senza minino affanno; ogni sguardo, gesto, movimento è caratterizzato da una determinante naturalezza mai indebolita, spintonando lo spettatore verso un immediato magnetismo impossibile da gestire e scalfendo forse inconsapevolmente l’interiorità di coloro che guardano. Grande protagonista del cinema neorealista (compreso fondamentalmente tra il 1943 e il 1955), collabora nel 1951 con Luchino Visconti alla realizzazione del film Bellissima, in cui “diventa” Maddalena Cecconi, madre mossa dal desiderio anche sconsiderato di rendere famosa la piccola figlia Maria. Altra tappa significativa ancora diretta da Visconti è quella di Siamo donne del 1953, film composto da quattro episodi nel quale l’interprete, grazie anche alla sceneggiatura di Suso Cecchi D’Amico e Cesare Zavattini, riesce meglio a esprimere la propria comicità battibeccando con un tassista che le vuole far pagare un tassa supplementare per il bassotto che lei porta con sé. La Magnani è colei che corre verso la propria abitazione dopo aver saputo della morte del figlio nell’opera del 1962 diretta da Pasolini e che porta il titolo di Mamma Roma, è quella che in un carcere schiaffeggia con forza un’altra detenuta nel film di Castellani Nella Città l’inferno girato nel 1959, che crea esilaranti siparietti affiancando Totò in Risate di gioia del 1960 diretto da Mario Monicelli.
L’uscita della biografia su Anna Magnani (edita da Bompiani, 400 pagine, 19 euro) scritta da Matilde Hochkofler con la collaborazione di Luca Magnani (figlio dell’attrice) rappresenta un evento per rimarcare l’immenso e immortale talento di un temperamento interpretativo che sempre costituirà un vanto della nostra cultura cinematografica. La Hochkofler è dedita da anni al cinema italiano e della Magnani ha già scritto più volte (Anna Magnani Lo spettacolo della vita del 2005 per Bulzoni editore; Anna Magnani, sempre del 2005, per Gremese editore) occupandosi nel 2004 della mostra fotografica Ciao Anna ai musei Capitolini di Roma. Il contributo inedito di Luca Magnani resta fondamentale per la stesura del testo. Una collaborazione offerta per via dell’impegno che l’autrice ha dedicato nel corso degli anni all’interprete romana. La Hochkofler presenta in maniera minuziosa e descrittiva le vicissitudini della Magnani; l’eterno e costante bisogno d’amore, l’indole contraddittoria nella sua fragilità ma densa di una forte e distintiva personalità, la lesione forse mai colmata inerente all’allontanamento della madre, la lealtà e le intemperanze di un carattere in qualche modo bisognoso, e coerente verso l’arte e il pubblico. La testimonianza di Luca è una chiave di svolta fresca nel raccontare la vita della madre ma soprattutto il loro complicato rapporto, apparentemente distaccato e denso di contrasti, ma che in un futuro “adulto” si definirà come forte collante caratterizzato da profondo affetto. L’autrice dunque articola un testo su due binari paralleli per ricordare, con equilibrio, vita privata e artistica di un personaggio intramontabile tuttora presente nell’attuale. Non importa se della Magnani (classe 1908) si è detto e scritto di tutto perché di fronte a una personalità così espansa non resta che arrendersi. Tuttora, infatti, può servire ad esempio per essere punto di riferimento di tutte quelle giovani attrici che aspirano a oltrepassare la linea dell’approssimazione recitativa. Nazional popolare e internazionale grazie a una presenza scenica che si mescola con sfaccettature rurali e raffinate, l’interprete romana disegna durante l’arco di tutta la sua carriera ruoli che riflettono uno schema ben disegnato attraverso virtuosismi recitativi che rimandano a quelli cantati dalla Callas dei tempi migliori. Tutto appare senza minino affanno; ogni sguardo, gesto, movimento è caratterizzato da una determinante naturalezza mai indebolita, spintonando lo spettatore verso un immediato magnetismo impossibile da gestire e scalfendo forse inconsapevolmente l’interiorità di coloro che guardano. Grande protagonista del cinema neorealista (compreso fondamentalmente tra il 1943 e il 1955), collabora nel 1951 con Luchino Visconti alla realizzazione del film Bellissima, in cui “diventa” Maddalena Cecconi, madre mossa dal desiderio anche sconsiderato di rendere famosa la piccola figlia Maria. Altra tappa significativa ancora diretta da Visconti è quella di Siamo donne del 1953, film composto da quattro episodi nel quale l’interprete, grazie anche alla sceneggiatura di Suso Cecchi D’Amico e Cesare Zavattini, riesce meglio a esprimere la propria comicità battibeccando con un tassista che le vuole far pagare un tassa supplementare per il bassotto che lei porta con sé. La Magnani è colei che corre verso la propria abitazione dopo aver saputo della morte del figlio nell’opera del 1962 diretta da Pasolini e che porta il titolo di Mamma Roma, è quella che in un carcere schiaffeggia con forza un’altra detenuta nel film di Castellani Nella Città l’inferno girato nel 1959, che crea esilaranti siparietti affiancando Totò in Risate di gioia del 1960 diretto da Mario Monicelli.
 Citare ora la filmografia completa e le rappresentazioni teatrali della Magnani appare quasi impossibile ma una parentesi importante resta quella americana, grazie alla quale l’attrice vinse un Oscar nel 1955 interpretando Serafina delle Rose nel film La rosa tatuata (The Rose Tattoo) di Daniel Mann scritto e sceneggiato da Tennessee Williams. Altra nomination all’Oscar la ottenne nel 1957 grazie al personaggio di Gioia nella pellicola Selvaggio è il vento (Wild is the wind) per la regia di George Cukor. Collaborazioni per la televisione risalgono invece al 1971 sotto la direzione di Alfedo Giannetti assieme al quale realizza La sciantosa, 1943: Un incontro e L’automobile; ciclo basato sulla fotografia di tre diverse figure femminili in cui il talento della Magnani risulta ancora integro. Torna in Teatro durante gli anni sessanta, scanditi da La lupa di Giovanni Verga diretta nel 1965 da Zeffirelli e Medea di Jean Anouilh, opera del 1966 con la regia di Giancarlo Menotti . L’attrice decise di intraprendere nuovi allestimenti benché a suo dire non le venivano offerte parti cinematografiche che le piacessero. Ebbene se la sequenza principale che più resta scolpita nella memoria collettiva è quella in cui, ricoprendo il ruolo di Pina, viene uccisa dai soldati nazisti mentre corre dietro al camion dei tedeschi in cui è rinchiuso il marito (scena facente parte del capolavoro di Roberto Rossellini Roma Città Aperta del 1945), non va’ dimenticato che la Magnani ha fatto suoi tanti altri ritratti femminili all’interno di una vastissima produzione teatrale e cinematografica. Riuscire a trovare un aspetto nuovo inerente alla capacità comunicativa di questo personaggio resta pressoché impossibile; ogni visione è rappresentativa del fatto che gli aspetti stessi tornano nuovi continuamente nei dettagli e nella gestualità di questa interprete simbolo della città di Roma, come se ci si trovasse di fronte a combinazioni numeriche dalle possibilità infinite. Una grande protagonista rappresentativa di un’epoca, una figura che resta moderna in grado di muoversi all’interno di un’opera come un direttore d’orchestra dirige i suoi orchestrali.
Citare ora la filmografia completa e le rappresentazioni teatrali della Magnani appare quasi impossibile ma una parentesi importante resta quella americana, grazie alla quale l’attrice vinse un Oscar nel 1955 interpretando Serafina delle Rose nel film La rosa tatuata (The Rose Tattoo) di Daniel Mann scritto e sceneggiato da Tennessee Williams. Altra nomination all’Oscar la ottenne nel 1957 grazie al personaggio di Gioia nella pellicola Selvaggio è il vento (Wild is the wind) per la regia di George Cukor. Collaborazioni per la televisione risalgono invece al 1971 sotto la direzione di Alfedo Giannetti assieme al quale realizza La sciantosa, 1943: Un incontro e L’automobile; ciclo basato sulla fotografia di tre diverse figure femminili in cui il talento della Magnani risulta ancora integro. Torna in Teatro durante gli anni sessanta, scanditi da La lupa di Giovanni Verga diretta nel 1965 da Zeffirelli e Medea di Jean Anouilh, opera del 1966 con la regia di Giancarlo Menotti . L’attrice decise di intraprendere nuovi allestimenti benché a suo dire non le venivano offerte parti cinematografiche che le piacessero. Ebbene se la sequenza principale che più resta scolpita nella memoria collettiva è quella in cui, ricoprendo il ruolo di Pina, viene uccisa dai soldati nazisti mentre corre dietro al camion dei tedeschi in cui è rinchiuso il marito (scena facente parte del capolavoro di Roberto Rossellini Roma Città Aperta del 1945), non va’ dimenticato che la Magnani ha fatto suoi tanti altri ritratti femminili all’interno di una vastissima produzione teatrale e cinematografica. Riuscire a trovare un aspetto nuovo inerente alla capacità comunicativa di questo personaggio resta pressoché impossibile; ogni visione è rappresentativa del fatto che gli aspetti stessi tornano nuovi continuamente nei dettagli e nella gestualità di questa interprete simbolo della città di Roma, come se ci si trovasse di fronte a combinazioni numeriche dalle possibilità infinite. Una grande protagonista rappresentativa di un’epoca, una figura che resta moderna in grado di muoversi all’interno di un’opera come un direttore d’orchestra dirige i suoi orchestrali.

