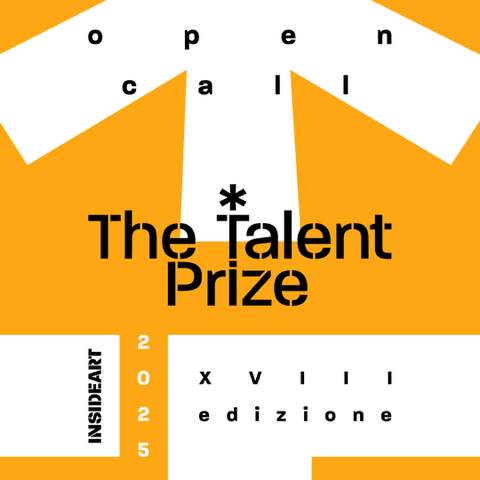L’opera di Luca Vitone ad alcuni può sfuggire. Ma può produrre l’effetto opposto fino anche a turbare per la perseveranza con cui richiama l’attenzione. Si percepisce in tutto il Padiglione Italiano. Vi è un odore che racconta una storia. Per l’eternità è una “scultura acromatica monolfattiva su tre note”: essenza di rabarbaro svizzero come nota di testa, quella assoluta di rabarbaro belga come nota di cuore, e rabarbaro essenza Francia come nota di fondo.
L’opera di Luca Vitone ad alcuni può sfuggire. Ma può produrre l’effetto opposto fino anche a turbare per la perseveranza con cui richiama l’attenzione. Si percepisce in tutto il Padiglione Italiano. Vi è un odore che racconta una storia. Per l’eternità è una “scultura acromatica monolfattiva su tre note”: essenza di rabarbaro svizzero come nota di testa, quella assoluta di rabarbaro belga come nota di cuore, e rabarbaro essenza Francia come nota di fondo.
Vitone lavora sempre sulla riflessione del concetto di luogo: in questo caso particolare propone in un linguaggio insolito – ma non inedito per lui – una parte di storia italiana, o meglio, degli italiani. L’azione di respirare questo caratteristico profumo – senza accorgersene inizialmente, o anche dopo molto tempo che ci si trova nel Padiglione Italiano – rievoca l’inconsapevole inspirazione delle polveri di Eternit da parte di tanti lavoratori delle vecchie fabbriche, ma anche più in generale della popolazione che vive a contatto con questo materiale, che è stato a lungo impiegato in edilizia per produrre lastre, tegole, materiali di copertura o di fondo per selciati, e per la costruzione di acquedotti.
Il fibrocemento è notoriamente considerato tossico e cancerogeno per la dispersione delle sue polveri, la sua produzione è stata bloccata solo agli inizi degli anni Novanta, nonostante si sapesse già da una trentina di anni dei danni che poteva arrecare. Luca Vitone investiga da vicino un caso in particolare: a Casale Monferrato (Alessandria) la fabbrica è stata chiusa nel 1986. I morti sono e saranno migliaia, a causa degli enormi aeratori che disperdevano le polveri in città. E vuole riportarci in quel luogo, o in qualunque altro luogo, di fronte a qualsiasi altra impercettibile tragedia, col respiro. Ascolto la gente chiedersi da dove venga questo profumo che si avverte ovunque ma di cui non si trova la sorgente, e riesco a farmi indicare la macchina erogatrice: due semplici buchi nel muro.
La sua è l’opera più invisibile di questa Biennale, ma sicuramente la più pervasiva.
«Forse fa parte dell’invisibilità che ci circonda».
Lavora sempre sull’invisibile?
«Non sempre. Certamente ho già lavorato sull’idea di invisibilità, ma anche con degli oggetti visibili, e questo è proprio l’inizio del mio percorso a fine anni Ottanta. Allora si intitolavano esattamente L’invisibile informa il visibile, che però sono opere diverse rispetto a questa, che raccontavano l’invisibilità come percorso conoscitivo, come vincere l’invisibilità con un percorso conoscitivo. Questo è un odore che parla di una polvere».
Ci sono molte persone dietro questo odore. Ci siamo noi che lo respiriamo, ma soprattutto tutte le persone che hanno lavorato sotto questa polvere.
«È un’evocazione di quella polvere – che è una polvere nociva, mentre questa è assolutamente naturale. È la terza volta che lavoro in questo modo, in questa direzione, ma mai forse in maniera così radicale, solamente l’odore e nient’altro».
Ci sono due narici.
«È una giusta osservazione – lei è la prima che me lo dice».
E nessuna didascalia accanto.
«Lì vicino no. All’interno della sala vi è già una spiegazione sufficiente. La scultura è gigantesca e ti avvolge e non c’è bisogno di aggiungere altro. Anche perché l’idea, il progetto, di lavorare sull’invisibilità non vuole assolutamente far vedere un oggetto che possa in qualche modo raccontare o togliere l’attenzione da questa immaterialità».