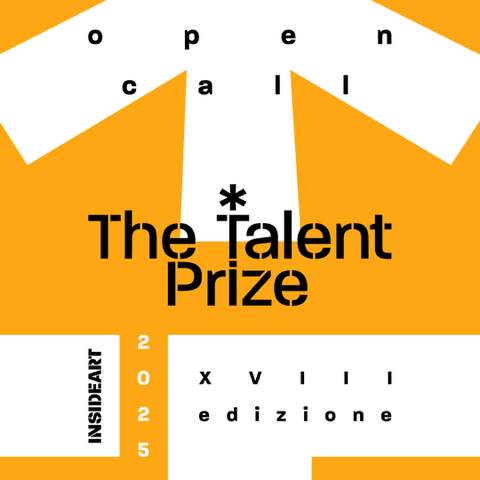Il tribunale di Roma ha disposto la confisca sei opere rubate nel centro e nel sud Italia che al momento si trovano esposte al Museo del Louvre. La decisione deriva dal fatto che si tratta di reperti trafugati e poi venduti al museo: Il Louvre avrebbe quindi acquistato in passato queste sei opere (tra vasi, anfore e sculture) di provenienza illegale. All’udienza tecnica per arrivare alla confisca dei beni presenzierà anche la direttrice del museo Laurence Des Cars.
Il fenomeno dei “tombaroli”
Un fatto che, per quanto possa sembrare sconcertante, non è poi così insolito. Il caso dei cosiddetti “tombaroli”, difatti, per molti anni ha influenzato molto il mercato. Alice Rohrwacher ha raccontato in maniera puntuale questo fenomeno nel film “La chimera”: ambientato negli anni ’80, narra la storia di Arthur, un giovane archeologo britannico coinvolto in una banda di tombaroli che saccheggiano tombe etrusche per rivendere i manufatti nel mercato nero. Questo tema si inserisce in un contesto storico ben preciso, ossia il traffico illecito di reperti archeologici in Italia, un fenomeno che ha avuto un forte impatto sulla conservazione del patrimonio culturale del Paese.
Negli anni ’70 e ’80, il saccheggio di siti archeologici divenne un problema diffuso nella penisola, soprattutto tra Lazio, Toscana e Umbria, dove si trovano numerose necropoli etrusche. Le tombe contenevano manufatti di grande valore storico e artistico che venivano rubati per essere venduti a collezionisti privati e musei internazionali.
Negli anni ’80, l’Italia iniziò a intensificare le indagini contro il traffico illegale di reperti archeologici. Il caso più eclatante fu quello del trafficante d’arte Giacomo Medici, coinvolto in un vasto traffico di reperti destinati a musei come il Getty Museum di Los Angeles e il Metropolitan Museum di New York. Questi traffici spesso si svolgevano grazie a documenti falsificati e all’intervento di esperti e galleristi che creavano una copertura legale per i pezzi rubati.

Il caso del Louvre
Le sei opere in questione ora esposte al Museo del Louvre avrebbero subito questo stesso iter. Per questo il tribunale di Roma ne ha ordinato la confisca in quanto ritenuti patrimonio del Paese. Dal 2018 è iniziato un intenso scambio di comunicazioni tra il Ministero della Cultura e il museo francese, con l’obiettivo di trovare un accordo che consentisse la restituzione delle opere all’Italia senza compromettere l’immagine del Louvre. Tuttavia, la questione verrà risolta in tribunale nei prossimi mesi, quando, durante l’udienza decisiva per la confisca dei beni, sarà presente anche la direttrice del museo parigino, Laurence Des Cars.
Un tesoro conteso: il viaggio dell’architrave perduto
Al centro della disputa tra Italia e Francia sono anfore, rilievi in terracotta e vasi. Tra i reperti contesi spicca una storia particolarmente emblematica: quella dell’architrave in pietra della chiesa di San Nicola di Bari ad Avezzano, in Abruzzo. Della parrocchia, devastata dal terremoto del 1915 e poi saccheggiata, rimase ben poco: quasi tutto fu trafugato, compreso l’architrave, che nel 1935 la galleria parigina Edgar Altounian mise in commercio.. Proposto al Louvre per 75 mila franchi, il museo rifiutò l’acquisto. Il reperto, però, continuò il suo viaggio attraverso l’Europa e, durante l’occupazione nazista, un collezionista lo vendette per 300 mila franchi al Kunstgewerbemuseum di Düsseldorf. Gli eventi bellici segnarono poi il destino del manufatto: con il bombardamento del museo tedesco, le truppe francesi lo riportarono a Parigi.
Dal 21 dicembre 1983 l’architrave è esposto al Louvre come uno dei capolavori del Rinascimento italiano. Tuttavia, gli atti dell’indagine condotta dal reparto operativo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale ricostruiscono la vicenda. Il pubblico ministero Stefano Opilio sottolinea che “Le autorità francesi e il Louvre erano consapevoli della provenienza italiana dell’architrave e avrebbero dovuto segnalarla al Ministero della Cultura già nel 1935”. La controparte francese, invece, sostiene che la chiesa fosse abbandonata dal 1874 e che il reperto fosse già entrato nella collezione dell’antiquario Altounian nei primi decenni del Novecento. L’Italia, però, ribadisce la sua posizione: l’architrave resta un bene del patrimonio nazionale.