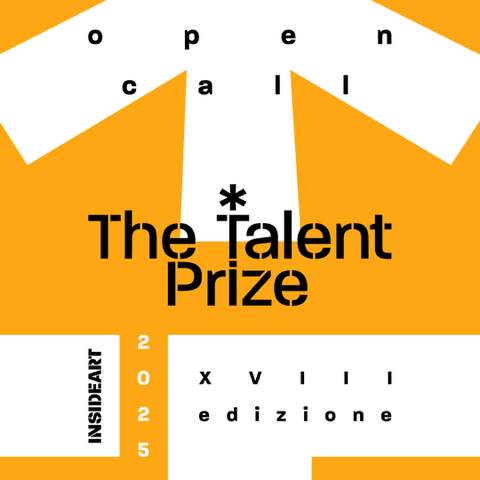Sarà visitabile fino al prossimo ottobre la mostra Patrimonio Dissidente, dell’artista Cosimo Veneziano (Moncalieri, 1983), al primo piano del MAC, il Museo di Arte Contemporanea di Lissone. La mostra è curata da Connecting Cultures, organizzazione fondata nel 2001 da Anna Detheridge (autrice anche del testo introduttivo alla mostra) con il principale obiettivo, come si legge sul sito web ufficiale, di “promuovere la sostenibilità nelle comunità locali attraverso l’arte e il design” in modo da rendere davvero i loro abitanti cittadini attivi e consapevoli.


La mostra espone un gruppo di quattordici opere, dal titolo Patrimonio dissidente (2024), costituite da immagini fotografiche di altrettanti monumenti, colorate manualmente dall’artista con anilina e montate a coppie entro sette cornici in legno, che ricordano delle casse da spedizione. A completare il percorso vi è anche Timeless (2024), una serie di quattordici disegni monocromi su lastre di gres, appoggiate su mensole appese al muro, che rappresentano le varie fasi della vita di un monumento, dalla sua costruzione, passando per l’inaugurazione (che può essere acclamata oppure aspramente criticata), fino alla sua eventuale vandalizzazione, depredazione o addirittura eliminazione.


Osservando le varie scene rappresentate sulle tavolette in pietra (che richiama direttamente il materiale con cui gran parte dei monumenti è di solito realizzata), notiamo infatti, per esempio, Silvio Berlusconi in mezzo alla folla mentre osserva il monumento a lui dedicato da Pietro Cascella a Milano 2 (1988), oppure un attivista mentre imbratta con della vernice la statua che Vito Tongiani ha dedicato a Indro Montanelli, presso i giardini di Via Palestro a Milano.


Analogamente, le immagini di Patrimonio dissidente ci mostrano i monumenti più disparati, come le già citate sculture dedicate alle controverse figure dell’ex premier e di Montanelli oppure la Violata, inaugurata nel 2013 ad Ancona come monumento contro la violenza sulle donne, che ha però suscitato aspre polemiche a causa della rappresentazione irrispettosa e stereotipata della figura femminile da essa veicolata. O, ancora, la Stele di Axum, antico monumento del regno africano di Axum, trafugato negli anni Trenta dai soldati italiani e riportato in Etiopia soltanto nel 2003, peraltro non senza difficoltà.

Non mancano, infine, esempi di monumenti che negli ultimi anni sono stati al centro delle cronache internazionali poiché oggetto di azioni contestatorie da parte di gruppi di attivisti, quali la statua di Edward Colston (mercante e schiavista), gettata nel fiume Bristol nell’ambito delle proteste legate al movimento Black Lives Matter, oppure quelle di Cristoforo Colombo (esploratore che ha cambiato la geografia del mondo moderno per alcuni, sterminatore violento per altri, nonché simbolo del colonialismo genocida occidentale), aggredite più volte in occasione del Colombus Day.
Tutti monumenti – insomma – con storie, caratteristiche e destini diversi che nelle fotografie di Veneziano sembrano però aver perso la loro proverbiale solidità: le loro tinte opache e spente contrastano infatti nettamente con la vivacità dei colori del paesaggio in cui essi sono immersi, creando delle atmosfere talvolta un po’ metafisiche, alla De Chirico, ed evidenziando la differenza tra la staticità di queste figure in pietra o metallo e la carica vitale della natura che le circonda (“Ho dipinto quello che c’è dietro ai monumenti perché volevo sottolineare il distaccamento che c’è tra il paesaggio in continuo movimento e la staticità di queste statue. Ho voluto dare maggior risalto al contesto e ho voluto restituire, attraverso la tecnica ad anilina con i pigmenti sciolti direttamente sulla fotografia, la presenza molto forte della natura” afferma l’artista stesso).
In queste scene un po’ stranianti, le figure quasi larvali dei monumenti sembrano chiamarci in causa: molti di essi appartengono a epoche storiche o sono dedicate a personalità quantomeno controverse, che devono portarci a riflettere sul significato che i monumenti detengono all’interno della società. Lungi dall’essere mero arredo urbano, infatti, essi costituiscono un determinante veicolo di significati storici e politici, in quanto espressione della visione e dei valori di coloro che li hanno voluti (tipicamente, le istituzioni che detengono il potere all’interno della comunità e la governano).

Quando però tali valori non vengono condivisi o sono riconosciuti come problematici da parte di gruppi più o meno ampi all’interno della società, ecco che i monumenti possono diventare (come abbiamo avuto modo di constatare spesso negli ultimi anni) oggetto di contestazioni più o meno violente, nel tentativo di risemantizzarli e di accendere l’opinione pubblica attorno al loro significato, evidenziandone soprattutto gli aspetti più politicamente e socialmente critici. Non distruzione fine a se stessa, insomma, come si potrebbe pensare, bensì un’operazione critica nel tentativo di costruire qualcosa di diverso, di nuovo, ritagliandosi uno spazio d’espressione entro il dibattito pubblico per poter affermare il proprio punto di vista e dare impulso al cambiamento.
Per quanto tali operazioni di contestazione non siano direttamente il soggetto delle opere di Veneziano ospitate dal MAC, esse vengono comunque richiamate in modo esplicito (e inevitabile) alla nostra mente, invitandoci a non dimenticare come i monumenti giochino sempre un ruolo di specchio dei valori e della politica di una comunità e, di conseguenza, non possano non configurarsi come terreno di confronto, scontro e rivendicazione, almeno in una società che si possa definire libera.
Dal 15 giugno al 6 ottobre 2024
Museo d’Arte Contemporanea, Lissone, Via Elisa Ancona 6, 20851
info: MAC