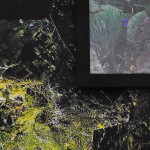Via Paisiello, a Milano, è un interessante mix di sapori e stili: la viuzza si insinua in quella cerchia meneghina costellata di piccole botteghe e palazzine ottocentesche e liberty, con (ancora) qualche spazio verde che dà loro respiro, e il vicinissimo caotico corso Buenos Aires; siamo in pieno centro, ma siamo anche altrove. Al civico 6 di questa bizzarra via si trova FuturDome, palazzo liberty tra i più interessanti di Milano, oggetto negli ultimi dieci anni di un intenso progetto di riqualifica non solo urbana, ma anche, e soprattutto, identitaria, che parte dal desiderio di recuperare antichi spazi di rilevanza storico-culturale (questo, in particolare, era la sede dell’ultima generazione degli artisti futuristi italiani allievi di Filippo Tommaso Marinetti) per formulare un nuovo concetto di ospitalità nella quale le parti comuni e gli appartamenti si trasformano in possibili spazi espositivi.
Via Paisiello, a Milano, è un interessante mix di sapori e stili: la viuzza si insinua in quella cerchia meneghina costellata di piccole botteghe e palazzine ottocentesche e liberty, con (ancora) qualche spazio verde che dà loro respiro, e il vicinissimo caotico corso Buenos Aires; siamo in pieno centro, ma siamo anche altrove. Al civico 6 di questa bizzarra via si trova FuturDome, palazzo liberty tra i più interessanti di Milano, oggetto negli ultimi dieci anni di un intenso progetto di riqualifica non solo urbana, ma anche, e soprattutto, identitaria, che parte dal desiderio di recuperare antichi spazi di rilevanza storico-culturale (questo, in particolare, era la sede dell’ultima generazione degli artisti futuristi italiani allievi di Filippo Tommaso Marinetti) per formulare un nuovo concetto di ospitalità nella quale le parti comuni e gli appartamenti si trasformano in possibili spazi espositivi.

Il titolo della mostra aperta fino al 30 novembre che si dirama per tutto il palazzo, è The Habit of a Foreign Sky, citazione presa da una poesia del 1864 di Emily Dickinson scritta poco prima di una dolora operazione agli occhi che avrebbe potuto portarla alla cecità. Nei versi, come scrive Ginevra Bria, ”la poetessa risiede le immensità aperte dell’America a partire dalla propria interiorità domestica. Le parole si domandano se nel compiere la visita di altre case, di intimità dimensionali, sia possibile diventare capaci di comprendere, sovrapponendosi, alla diversità dell’Altro”.

Ed è proprio lo ”spazio della possibilità” che viene preso in esame nella collettiva The Habit of a Foreign Sky, a cura di Isisuf – Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo che raccoglie la voce di dieci artisti trentenni italiani che hanno fatto del cielo straniero la loro nuova casa. Nel palazzo aperto e in transito dalla dimensione pubblica a quella privata Enrico Boccioletti, Guglielmo Castelli, Alessandro di Pietro, Michele Gabriele, Diego Miguel Mirabella, Giovanni Oberti, Ornaghi & Prestinari, Valentina Perazzini e Jonathan Vivacqua sono stati chiamati ad agire all’interno di appartamenti vuoti, case che non sono ancora case, per creare ambienti site specific. Un’operazione che scardina l’idea stessa di mostra collettiva, di spazio museale, di arte pubblica e che vuole offrire l’opportunità di attivare unità abitative (invece di spazi espositivi), fornendo ad artisti e progetti l’esperienza di risiedere.

Il percorso allestito è una faticosa ascesa che dalle cantine tetre e scricchiolanti arriva fino all’attico della palazzina; meglio sarebbe dire che The Habit of a Foreign Sky è una storia, dove ogni appartamento è un capitolo. Prologo e conclusione sono i due vertici di un cerchio che si chiude trovando il suo equilibrio perfetto; il racconto che si costruisce nel mezzo è fatto di ricordi, ironia, mestieri; è fatto della città che sfacciatamente (con la sua bellezza inaspettata) si insinua nello spazio in divenire, del dialogo tra natura – quella sognata – e il cemento. È fatto di tanta luce. Accecante. A tratti metafisica. La mostra coinvolge lavori estremamente diversi tra loro (video installazioni, installazioni sonore, opere pittoriche e scultoree, design, fotografie), ma ha degli elementi comuni che rendono questo percorso accogliente e includente: l’ampiezza degli spazi democraticamente uguale per tutti e la loro condizione a rustico; la possibilità di utilizzare gli elementi del cantiere, i vecchi mobili e le maestranze (ad esempio di Knauf – main sponsor del progetto – impegnate nella ristrutturazione dell’immobile) all’interno dei loro lavori; la luce che si scalda man mano che si sale verso l’attico. La coralità dell’esposizione assume, così, un equilibrio perfetto. Non si conoscono questi spazi, ma ci accolgono, si fanno leggere, ci danno la possibilità di lasciare delle tracce e di renderli completi. Una comunità indefinita, per tornare alla Dickinson, che sotto il cielo straniero, perde l’io e lascia spazio al noi.