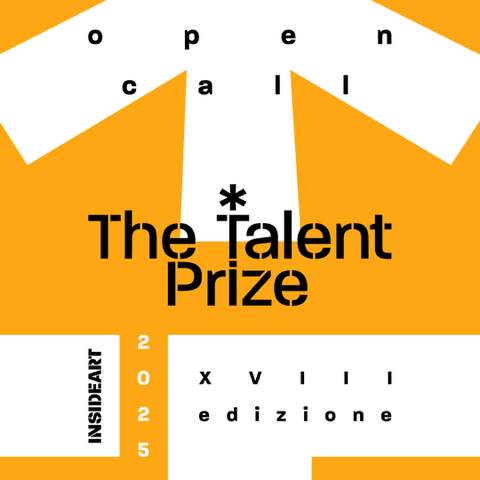Multiculturalismo, globalizzazione intellettuale, estetica digitale, ma di cosa parliamo quando parliamo di post-contemporaneo? Il collettivo newyorkese DIS, aka Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso e David Toro, nella loro personale visione curatoriale della nona edizione della Biennale di Berlino sembrano voler rispondere a questa domanda emblematica analizzando attraverso l’arte un percorso che ingloba la concezione del presente (the Present in Drag) e delle sue futuribili realtà. Berlino è un luogo sintomatico, crogiolo linguistico, politico e sociologico di differenti peculiarità estetico – narrative, una città che ha vissuto nel ‘900 tutte le trasformazioni politiche e culturali dettate dagli orrori della storia. Eppure, intrufolandosi nel labirintico allestimento proposto dal collettivo DIS, il presente sembra piuttosto un latitante. Video arte, installazioni, progetti site specific, confondono lo spettatore e lo proiettano in una dimensione autoreferenziale, dove artisti, consumati o meno, ammiccano ad un’estetica elitaria, volutamente ermetica e afona. Cercando una chiave di lettura, bisognerebbe cominciare con una definizione di post – moderno e in questo campo cognitivo Nicolas Bourriaud, filosofo francese e autore del famigerato saggio Il Radicante, ha definito le caratteristiche di un fenomeno intellegibile: “La post – storia è un concetto vuoto, proprio come quello di post – modernità ha un senso meramente circostanziale, poiché riveste il ruolo di un software di gestione del dopo modernismo. Il prefisso “post” del quale si può assaporare l’ambiguità, in fondo non è servito ad altro che a federare le varie versioni di questo dopo, da un post – strutturalismo fino a opzioni chiaramente passatiste”. Il presente, secondo il postulato di Bourriaud, non significa arrischiarsi di cogliere l’occasione, significa non essere soddisfatti della tradizione, delle categorie esistenti, bisogna aprire nuovi cammini, fare da guida.
Multiculturalismo, globalizzazione intellettuale, estetica digitale, ma di cosa parliamo quando parliamo di post-contemporaneo? Il collettivo newyorkese DIS, aka Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso e David Toro, nella loro personale visione curatoriale della nona edizione della Biennale di Berlino sembrano voler rispondere a questa domanda emblematica analizzando attraverso l’arte un percorso che ingloba la concezione del presente (the Present in Drag) e delle sue futuribili realtà. Berlino è un luogo sintomatico, crogiolo linguistico, politico e sociologico di differenti peculiarità estetico – narrative, una città che ha vissuto nel ‘900 tutte le trasformazioni politiche e culturali dettate dagli orrori della storia. Eppure, intrufolandosi nel labirintico allestimento proposto dal collettivo DIS, il presente sembra piuttosto un latitante. Video arte, installazioni, progetti site specific, confondono lo spettatore e lo proiettano in una dimensione autoreferenziale, dove artisti, consumati o meno, ammiccano ad un’estetica elitaria, volutamente ermetica e afona. Cercando una chiave di lettura, bisognerebbe cominciare con una definizione di post – moderno e in questo campo cognitivo Nicolas Bourriaud, filosofo francese e autore del famigerato saggio Il Radicante, ha definito le caratteristiche di un fenomeno intellegibile: “La post – storia è un concetto vuoto, proprio come quello di post – modernità ha un senso meramente circostanziale, poiché riveste il ruolo di un software di gestione del dopo modernismo. Il prefisso “post” del quale si può assaporare l’ambiguità, in fondo non è servito ad altro che a federare le varie versioni di questo dopo, da un post – strutturalismo fino a opzioni chiaramente passatiste”. Il presente, secondo il postulato di Bourriaud, non significa arrischiarsi di cogliere l’occasione, significa non essere soddisfatti della tradizione, delle categorie esistenti, bisogna aprire nuovi cammini, fare da guida.
Il presente narrato dai DIS è un cammino imbrigliato, fatiscente, a tratti vacuo, come, ad esempio nelle Unreplied Emails di Camille Henrot, laddove il non senso sfugge alla denominazione di un procedimento quotidiano, lettere perse, ritrovate, dai destinatari incerti sono piegate in terra alla vista di spettatori poco attenti, o ancora la video installazione di Cécile B. Evans, dove circondati dall’acqua scorrono immagini di un surrealismo indotto, orecchie che ascoltano footage di programmi televisivi provenienti dall’estremo oriente e che, attraverso la dialettica anglofona, riecheggiano nella sala dando un senso scomposto alle figure e ai suoi personaggi. Il linguaggio predominante è senz’altro di matrice pubblicitaria: l’arruolamento della pubblicità nel dialogo estetico contemporaneo è la sintesi di un “crogiolo in cui ribollono gli elementi di una sensibilità nuova che si prepara”, gli Stati Uniti e New York, in particolare, rappresentano la brandizzazione del reale, questo è il sentore univoco che il collettivo DIS è riuscito a portare nella vecchia Europa, il marchio come causa – effetto di un upgrade generazionale, dunque anche l’arte, come ogni altro qualsiasi elemento, diviene marchio effimero di un periodo storico. Un paio di jeans, un profumo, un’iconica borsa di pelle non sono altro che frutti di questo presente, ad uso e consumo estetico di una generazione votata all’iper realtà dettata da un dispositivo elettronico – digitale. In questa estetica il protagonista assente diviene esattamente il nostro presente storico, o come sottolineerebbe ancora una volta Bourriaud: “assistiamo all’emergere di una sorta di cortesia estetica, un’attitudine che consiste nel rifiutarsi di formulare il benché minimo giudizio critico per paura di urtare la suscettibilità dell’altro, in un’epoca in cui i particolarismi millenari vengono sradicati in nome dell’efficacia economica, facendo così dell’arte contemporanea un conservatorio delle trazioni e delle identità assottigliate nella realtà dalla globalizzazione”.
La nona edizione della Biennale di Berlino apre i battenti celebrando le contraddizioni del nuovo millennio, tessendo nuove ricerche culturali e favorendo scambi sociali ed internazionali. Se il risultato sia ben riuscito o meno forse è poco rilevante, la questione di fondo è la comprensione del mondo attuale e delle sue infinite possibilità, dunque, in conclusione, la domanda fondante è la seguente: Quanti artisti possono davvero ritenersi capaci di saper analizzare e trasmettere il presente? Ai posteri l’ardua sentenza.
Fino al 18 settembre 2016, Berlino, info: bb9.berlinbiennale.de