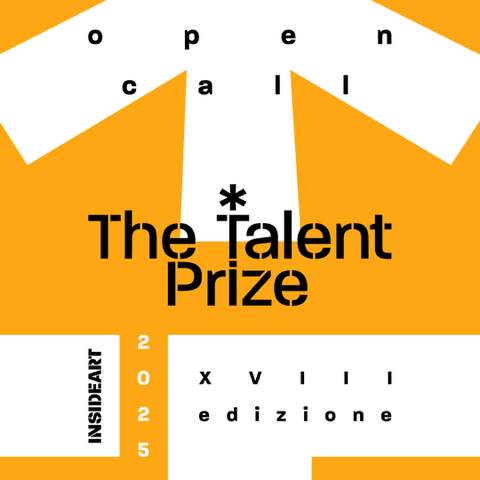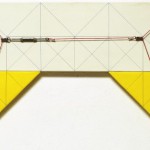 La fondazione Marconi presenta al pubblico una mostra incentrata su alcune opere degli anni Settanta dell’artista milanese Gianfranco Pardi, a due anni dalla sua scomparsa. L’intera opera di Pardi, di ambito strutturalista e concettuale, si basa sullo studio dello spazio e sul rapporto tra astrazione e costruzione. La costante, che attraversa tutto il suo percorso artistico, è l’integrazione rigorosa di pittura, disegno e scultura. La riflessione dell’artista sull’architettura inizia già a partire dalla fine degli anni Sessanta, con le prime raffigurazioni di interni ed esterni architettonici e successivamente con lavori chiamati, appunto, “architetture”. Quando lavoro attorno a un problema specifico che chiamo “architettura”, so di non parlare della architettura e so che il mio lavoro non agisce nel senso di produrre una sorta di astratta architettura. Eppure tutto il mio lavoro, da tempo, si istituisce espressamente attorno al senso di questo problema. Con “architettura” Pardi vuole intendere una modalità, un processo creativo, un mezzo attraverso il quale potersi concentrare sulle possibilità costruttive della forma, su esperienze plastiche, che evidentemente rimandano alle utopie dell’avanguardia, al suprematismo e al costruttivismo russi e al neoplasticismo olandese. La rilettura di Malevič, Tatlin, El Lisitzky e di altri protagonisti di quei movimenti, permette all’artista di cogliere gli elementi ancora vitali di quelle esperienze artistiche, facendone uno dei protagonisti e interlocutori più qualificati nelle vicende della pittura e scultura contemporanee. In quest’ottica si collocano la serie di progetti-studi realizzati con tecnica mista su carta. Poeticamente abita lʼuomo e l’installazione dallo stesso titolo, tratto da un verso del poeta tedesco Friedrich Hölderlin. Concepita da Pardi nel 1977, l’installazione, esposta al primo piano della fondazione, è complessa per riferimenti ed elaborazioni ma di rigorosa semplicità formale. Presentata per la prima volta in una mostra personale allo studio Marconi nel 1978, nasce da una riflessione sulla casa che il filosofo e ingegnere austriaco Ludwig Wittgenstein costruì a Vienna per la sorella nella seconda metà degli anni Venti.
La fondazione Marconi presenta al pubblico una mostra incentrata su alcune opere degli anni Settanta dell’artista milanese Gianfranco Pardi, a due anni dalla sua scomparsa. L’intera opera di Pardi, di ambito strutturalista e concettuale, si basa sullo studio dello spazio e sul rapporto tra astrazione e costruzione. La costante, che attraversa tutto il suo percorso artistico, è l’integrazione rigorosa di pittura, disegno e scultura. La riflessione dell’artista sull’architettura inizia già a partire dalla fine degli anni Sessanta, con le prime raffigurazioni di interni ed esterni architettonici e successivamente con lavori chiamati, appunto, “architetture”. Quando lavoro attorno a un problema specifico che chiamo “architettura”, so di non parlare della architettura e so che il mio lavoro non agisce nel senso di produrre una sorta di astratta architettura. Eppure tutto il mio lavoro, da tempo, si istituisce espressamente attorno al senso di questo problema. Con “architettura” Pardi vuole intendere una modalità, un processo creativo, un mezzo attraverso il quale potersi concentrare sulle possibilità costruttive della forma, su esperienze plastiche, che evidentemente rimandano alle utopie dell’avanguardia, al suprematismo e al costruttivismo russi e al neoplasticismo olandese. La rilettura di Malevič, Tatlin, El Lisitzky e di altri protagonisti di quei movimenti, permette all’artista di cogliere gli elementi ancora vitali di quelle esperienze artistiche, facendone uno dei protagonisti e interlocutori più qualificati nelle vicende della pittura e scultura contemporanee. In quest’ottica si collocano la serie di progetti-studi realizzati con tecnica mista su carta. Poeticamente abita lʼuomo e l’installazione dallo stesso titolo, tratto da un verso del poeta tedesco Friedrich Hölderlin. Concepita da Pardi nel 1977, l’installazione, esposta al primo piano della fondazione, è complessa per riferimenti ed elaborazioni ma di rigorosa semplicità formale. Presentata per la prima volta in una mostra personale allo studio Marconi nel 1978, nasce da una riflessione sulla casa che il filosofo e ingegnere austriaco Ludwig Wittgenstein costruì a Vienna per la sorella nella seconda metà degli anni Venti.