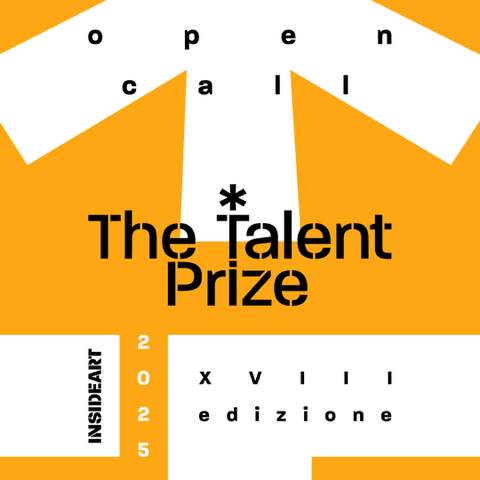A poco sono servite le sollecitazioni del mondo culturale italiano, a partire da quelle del ministro dei Beni culturali Massimo Bray, per tutelare la cosiddetta eccezione culturale. Poco fa a Lussemburgo ha avuto luogo un precedente eclatante nelle politiche di tutela della cultura europea. I ministri del Commercio dei 27 paesi Ue hanno disposto che nei negoziati con gli Stati Uniti per regolare lo scambio dei prodotti commerciali tra le due superpotenze la cultura sarà trattata alla stregua dei pomodori e degli insaccati. È caduto, dopo più di vent’anni di storia il principio per cui il settore della produzione culturale, tra cui il comparto audiovisivo, rispondeva a logiche più protezioniste rispetto ad altri mercati, per promuovere e tutelare la diversità e l’industria culturale. Una clausola che, sebbene rappresenti una piccola ombra nel deserto del libero mercato, è stata però la base della nascita di un vero indotto economico in Europa. Da circa mezzo secolo, infatti, questo criterio guida i negoziati commerciali tra l’Ue e le altre potenze internazionali. Ma oggi questo equilibrio è venuto meno, a vantaggio della grande macchina distributiva made in Usa. Dietro questa notizia, secca, tecnica e implacabile, si celano le paure di tutto il settore della produzione audiovisiva italiana: cinematografi, autori, registi, attori, produttori e dell’intero sistema occupazionale che ruota attorno alla pellicola, sia del piccolo che del grande schermo. Sono loro, infatti, le principali vittime delle possibili conseguenze di questo accordo. Le minacce, ancora una volta, vengono dal web, questa misteriosa e fantastica rete virtuale di cui in Europa si stenta a capire l’importanza. Senza l’eccezione culturale le grandi piattaforme online di distribuzione, Google, Apple, Netflix e Amazon, queste le principali, non a caso tutte statunitensi, possono diffondere in Europa i prodotti che preferiscono, quelli con più mercato, beneficiando delle reti di telecomunicazione europee. E senza nessun onere fiscale né contributivo nei confronti dei paesi Ue. Non solo, senza nemmeno l’obbligo di reinvestire in produzione culturale i proventi delle loro iniziative. La conseguenza drammatica, temuta dagli operatori europei, è che le agenzie di pubblicità sarebbero molto più allettate a spendere su un’offerta dall’utile sicuro e molto meno a puntare sulle produzioni europee che, sebbene meno danarose di quelle nordamericane, continuano ancora oggi a sfornare prodotti di assoluta qualità stilistica, artistica e concettuale.
A poco sono servite le sollecitazioni del mondo culturale italiano, a partire da quelle del ministro dei Beni culturali Massimo Bray, per tutelare la cosiddetta eccezione culturale. Poco fa a Lussemburgo ha avuto luogo un precedente eclatante nelle politiche di tutela della cultura europea. I ministri del Commercio dei 27 paesi Ue hanno disposto che nei negoziati con gli Stati Uniti per regolare lo scambio dei prodotti commerciali tra le due superpotenze la cultura sarà trattata alla stregua dei pomodori e degli insaccati. È caduto, dopo più di vent’anni di storia il principio per cui il settore della produzione culturale, tra cui il comparto audiovisivo, rispondeva a logiche più protezioniste rispetto ad altri mercati, per promuovere e tutelare la diversità e l’industria culturale. Una clausola che, sebbene rappresenti una piccola ombra nel deserto del libero mercato, è stata però la base della nascita di un vero indotto economico in Europa. Da circa mezzo secolo, infatti, questo criterio guida i negoziati commerciali tra l’Ue e le altre potenze internazionali. Ma oggi questo equilibrio è venuto meno, a vantaggio della grande macchina distributiva made in Usa. Dietro questa notizia, secca, tecnica e implacabile, si celano le paure di tutto il settore della produzione audiovisiva italiana: cinematografi, autori, registi, attori, produttori e dell’intero sistema occupazionale che ruota attorno alla pellicola, sia del piccolo che del grande schermo. Sono loro, infatti, le principali vittime delle possibili conseguenze di questo accordo. Le minacce, ancora una volta, vengono dal web, questa misteriosa e fantastica rete virtuale di cui in Europa si stenta a capire l’importanza. Senza l’eccezione culturale le grandi piattaforme online di distribuzione, Google, Apple, Netflix e Amazon, queste le principali, non a caso tutte statunitensi, possono diffondere in Europa i prodotti che preferiscono, quelli con più mercato, beneficiando delle reti di telecomunicazione europee. E senza nessun onere fiscale né contributivo nei confronti dei paesi Ue. Non solo, senza nemmeno l’obbligo di reinvestire in produzione culturale i proventi delle loro iniziative. La conseguenza drammatica, temuta dagli operatori europei, è che le agenzie di pubblicità sarebbero molto più allettate a spendere su un’offerta dall’utile sicuro e molto meno a puntare sulle produzioni europee che, sebbene meno danarose di quelle nordamericane, continuano ancora oggi a sfornare prodotti di assoluta qualità stilistica, artistica e concettuale.
Ma perché i membri dell’Ue hanno deciso per questa linea apparentemente autolesionista? La risposta è da ricercarsi nella complessa ma necessaria, a detta di molti, arte del compromesso: tutelare i rapporti con gli Usa senza puntare i piedi, in modo da difendere i prodotti che gli Usa importano in misura maggiore dall’Europa, quelli agroalimentari. Film e serie tv in cambio di pomodori e insaccati? Detta dal viceministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda, che per l’Italia ha seguito l’incontro a Lussemburgo, non è esattamente così, ma il senso è quello: «L’accordo con gli Stati Uniti è fondamentale per il riequilibrio delle relazioni commerciali e di investimento mondiali – ha detto – dall’analisi commissionata dal ministero risulta che l’Italia sarebbe il primo beneficiario in Europa, in termini di aumento delle esportazioni, in caso di positiva conclusione di quest’accordo». Non si è verificato, quindi, quanto chiedevano i registi che nei giorni scorsi hanno presentato una petizione al Parlamento europeo per ottenere che l’audiovisivo restasse fuori dall’accordo di libero scambio tra Usa e Ue. Daniele Luchetti è il capofila di questo movimento, che aggrega molte associazioni di categoria tra cui 100 Autori, l’associazione dell’autorialità cinetelevisiva, e a cui paradossalmente aderiscono anche registi Usa, gelosi di preservare la diversità dell’offerta nei contenuti: «Noi abbiamo chiesto che le trattative avvenissero su piani separati. Quello che temiamo – spiega Luchetti – è di essere fagocitati da un mercato senza regole, che finirà per scoraggiare le piccole produzioni e a eliminare completamente le nuove generazioni di registi e cineasti». Ma Calenda rassicura gli addetti ai lavori: «Qualora ci fosse richiesto di mettere a rischio la nostra cultura per raggiungere questi benefici, noi non saremmo d’accordo ad andare avanti. Nel mandato – ha sottolineato – è chiaramente specificato che la negoziazione non potrà pregiudicare la possibilità presente e futura, per l’Italia e per l’Europa, di sostenere il settore audiovisivo con quote e incentivi e di far evolvere la legislazione nazionale ed europea nei confronti dei nuovi operatori digitali, in qualunque modo si ritenga necessario». Sarà, ma Maurizio Sciarra, regista e vicepresidente della Federazione europea registi dell’audiovisivo, è consapevole dei rischi che questo accordo può comportare: «Stiamo favorendo un’apertura senza regole a una massiccia distribuzione statunitense di prodotto. Stiamo aprendo la strada a Google e alla Apple, che distribuiranno in primo luogo i loro prodotti».
Italia e Francia sono i paesi che, più degli altri, si sono impuntati per difendere l’industria audiovisiva nazionale. L’onorevole Silvia Costa, europarlamentare Pd in commissione cultura, è stata tra coloro che il 23 maggio scorso in Parlamento europeo hanno sostenuto in modo più incisivo la mozione di indirizzo, poi votata con una maggioranza di 380 voti (191 i contrari e 17 gli astenuti) per includere la difesa dell’eccezione culturale nella posizione ufficiale dell’Ue. Ha animato una forte azione di lobbying a favore della posizionedell’Italia. Ma invano: «Questa scelta mi lascia perplessa anche se le precisazioni fatte da Calenda non stemperano la mia delusione. Mantengo le mie perplessità e mi impegno affinché il Parlamento europeo sviluppoi la sua azione di vigilanza sull’adozione degli accordi». Anche Lorenzo Fontana, eurodeputato della Lega Nord in commissione cultura, comunica il suo rammarico: «Sicuramente, la mancata esclusione dal tavolo negoziale non rappresenta una buona notizia; né per l’universo culturale, né per il comparto dell’audiovisivo e per i settori a esso connessi. Non riteniamo di equiparare la cultura a una merce, questa convinzione è la direttrice alla base del nostro no». Cosa è mancato in questo accordo? Perché ancora una volta l’Europa ha rivelato un’unione molto precaria su uno dei temi che più la contraddistingue, la cultura? In realtà questo è il risultato di politiche approssimative che si perpetuano da molto tempo. Ne è convinta la stessa Costa: «Non abbiamo una definizione di prodotto audiovisivo online, non abbiamo legiferato sul diritto di autore europeo, siamo lontani dal regolamentare le connect tv, e abbiamo una direttiva sulla privacy presentata e non approvata, ma soprattutto non capiamo che in Ue esistono giganti della rete, tutti made in Usa, che senza nessuna regola utilizzano le nostre telecomunicazioni, su cui gli investimenti sono stati fatti l’Ue, ma sui quali non pagano tasse in Europa. E poi non reinvestono nella produzione, quando invece un operatore europeo per mettere un contenuto culturale sulle reti paga delle royalties». Ma non mancano i più maliziosi, come Sciarra: «Obama ha grossi problemi occupazionali in Usa», dice il regista, «per questo vuole fare rientrare in patria i colossi dell’informatica, come la Apple che adesso produce in tutto il mondo fuorché negli Stati Uniti. Stiamo salvando la loro crescita e svendiamo un’industria che negli Usa è seconda, dopo quella degli armamenti».