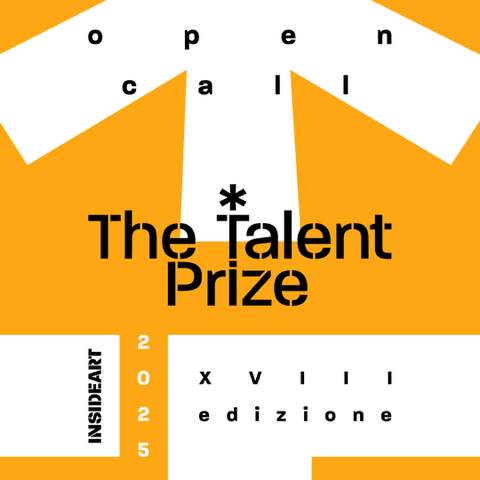Ci sono un italiano, un tedesco, un francese e uno spagnolo e si domandano se sia opportuno razionare i fondi statali alla cultura. Cosa succede? No, non è l’incipit di una barzelletta, ma la cornice di un dibattito molto attuale che è andato in scena ieri al Goethe Institut di Roma, l’ambasciata culturale tedesca nella capitale. Come in Germania l’anno scorso, anche in Italia il libro Kulturinfarkt, nella sua traduzione pubblicata quest’anno da Marsilio, ha sollevato un ginepraio di polemiche. Perché la questione che fa da leit motiv alle considerazioni degli autori è tanto rilevante quanto impopolare tra gli addetti ai lavori: è opportuno che la cultura sia sostenuta dai governi o è più saggio lasciare che siano le logiche del mercato a fornire l’offerta culturale? Nel libro la risposta è categorica ma interessante. Gli autori, Armin Klein, docente di managment culturale alla Padagogische Hochschule Ludwisburg, Stephan Opitz, fotografo, Dieter Haselbach, co-director of Zentrum fur Kulturforschung Gmbh e Pius Knusel, ex direttore della fondazione Pro Elvetia, propongono di reinventare il sistema dei fondi pubblici, smantellando il 50% delle strutture culturali nei loro paesi, in modo da avere più soldi per meno voci di spesa. Non solo. Propongono di indirizzare, poi, una rilevante parte dei fondi ad altri quattro settori: accademie, mondo amatoriale, digitalizzazione e rapporto con altre culture. Una teoria intrigante e acuta ma sufficiente a innescare la reazione congiunta dei personaggi riunitisi ieri: Pippo Ciorra, senior curator per l’architettura al Maxxi, Eric De Chassey, direttore dell’Accademia di Francia Villa Medici, Fabrizio Grifasi, direttore generale della fondazione Romaeuropa, la padrona di casa Susanne Hohn, direttrice del Goethe Institut di Roma e Sergio Rodriguez Lopez – Ros, direttore del Cervantes.
Ci sono un italiano, un tedesco, un francese e uno spagnolo e si domandano se sia opportuno razionare i fondi statali alla cultura. Cosa succede? No, non è l’incipit di una barzelletta, ma la cornice di un dibattito molto attuale che è andato in scena ieri al Goethe Institut di Roma, l’ambasciata culturale tedesca nella capitale. Come in Germania l’anno scorso, anche in Italia il libro Kulturinfarkt, nella sua traduzione pubblicata quest’anno da Marsilio, ha sollevato un ginepraio di polemiche. Perché la questione che fa da leit motiv alle considerazioni degli autori è tanto rilevante quanto impopolare tra gli addetti ai lavori: è opportuno che la cultura sia sostenuta dai governi o è più saggio lasciare che siano le logiche del mercato a fornire l’offerta culturale? Nel libro la risposta è categorica ma interessante. Gli autori, Armin Klein, docente di managment culturale alla Padagogische Hochschule Ludwisburg, Stephan Opitz, fotografo, Dieter Haselbach, co-director of Zentrum fur Kulturforschung Gmbh e Pius Knusel, ex direttore della fondazione Pro Elvetia, propongono di reinventare il sistema dei fondi pubblici, smantellando il 50% delle strutture culturali nei loro paesi, in modo da avere più soldi per meno voci di spesa. Non solo. Propongono di indirizzare, poi, una rilevante parte dei fondi ad altri quattro settori: accademie, mondo amatoriale, digitalizzazione e rapporto con altre culture. Una teoria intrigante e acuta ma sufficiente a innescare la reazione congiunta dei personaggi riunitisi ieri: Pippo Ciorra, senior curator per l’architettura al Maxxi, Eric De Chassey, direttore dell’Accademia di Francia Villa Medici, Fabrizio Grifasi, direttore generale della fondazione Romaeuropa, la padrona di casa Susanne Hohn, direttrice del Goethe Institut di Roma e Sergio Rodriguez Lopez – Ros, direttore del Cervantes.
La provocazione ha fatto unire i rappresentanti delle varie istituzioni culturali in un corale esame di coscienza: «Difficile immaginare una cultura non sostenuta dallo Stato, ma se penso che il report del consiglio d’Europa nel 2010 – ha detto Grifasi – ha illustrato come in Italia il finanziamento pubblico alla cultura sia di qualche miliardo superiore a quello della Germania, con la differenza che in Germania ci sono 150 teatri che hanno una troupe stabile di personale, mentre in Italia questo non esiste, viene da ritenere che da noi il problema non siano le sovvenzioni, ma il metodo in cui queste vengono utilizzate per le strutture». I soldi non mancano, quindi, ma sono spesi male. E a quanto pare questo problema non viene avvertito solo nel belpaese. Se la questione viene sollevata dagli autori germanofoni del libro vuol dire che anche a nord della Penisola gli osservatori sono critici sulle modalità di utilizzo del contributo pubblico. Ed è interessante riscontrare come la direttrice di un istituto di cultura tedesco prestigioso come il Goethe di Roma, Susanne Hohn, tiri fuori gli artigli di fronte all’ipotesi di una rivisitazione del sistema di aiuti pubblici per la cultura: «Se il mio istituto non fosse sovvenzionato – ha detto – non potrei organizzare proiezioni o altri eventi e questo sarebbe un peccato». Ma lo stesso dibattito applicato alla realtà italiana assume una tinta fosca che viene schiarita da Pippo Ciorra, che indaga su come il vero problema italiano sia nella duplice funzione che lo Stato si attribuisce: quella di elargire i denari e decidere come questi debbano essere spesi: «Il welfare culturale in Italia si inquina con rapporto tra società e politica – ha chiarito – la vicinanza troppo forte tra società e politica finisce per avere influenza cattiva sul modo in cui i soldi vengono spesi. Il compito della politica non deve essere quello di scegliere i curatori e i designers ma solo quello di creare strutture. La prima cosa da cambiare nel nostro sistema è il rapporto tra chi i soldi li dà e chi li riceve, che dovrebbe essere caratterizzato da una maggiore distanza e correttezza, con più elementi di filtro». E pensare che in Francia, come raccontato da De Chassey, la cultura viene vissuta come una questione di Stato e sarebbe impensabile scindere il rapporto tra Stato e cultura: «Basti pensare – ha detto De Chassey – che ogni presidente francese si caratterizza per la creazione di una grande istituzione culturale nel cuore di Parigi». L’emblema di una filosofia per cui la cultura diventa occasione di prestigio e autorevolezza.
Ma come provare a risolvere questo annoso problema? Cosa si può proporre per arginare il problema degli sperperi nella cultura? Le risposte sono arrivate da illustri esponenti del mondo intellettuale italiano, che non si sono sottratti al dibattito aperto dal libro Kulturinfarkt. Per Philippe Daverio il nostro paese ha bisogno d’aiuto: «Dobbiamo essere salvati dall’Occidente – scandisce – da molto tempo lancio lo slogan save Italy: noi siamo la culla dell’Occidente, ci devono dare una mano per salvarla». Più pragmatico Vittorio Sgarbi, che propone la creazione di un ministero del tesoro dei beni culturali, frutto della fusione del dicastero dell’Economia e di quello dei Beni culturali «per mantenere al meglio il nostro patrimonio». Salvatore Settis, invece, suggerisce di «triplicare i fondi dello Stato». Un unico problema e tante possibili soluzioni. E mentre in Italia imperversa una campagna elettorale in cui latitano progetti significativi per rilanciare la cultura è confortante riscontrare come il libro Kulturinfarkt, come un feticcio che minaccia i dogmi delle istituzioni culturali, abbia ripristinato un confronto molto esteso e utile su una problematica di interesse collettivo e da cui dipende la crescita dell’Europa.