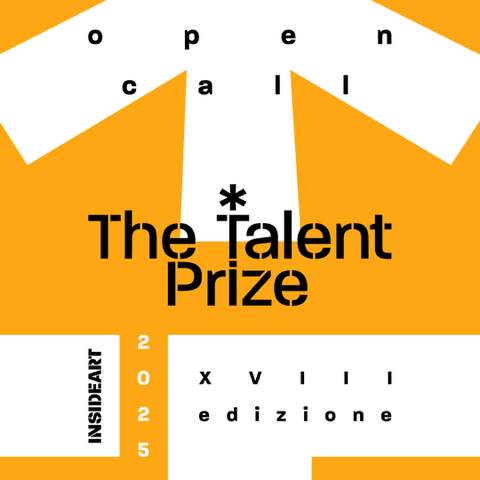GUARDA IL SERVIZIO di Maurizio Zuccari
Riprese di Cecilia Sica, montaggio di Camilla Mozzetti
 Sono stati oltre 140mila, alla fine, quelli che hanno staccato il biglietto d’ingresso per visitare Bronzino, a Firenze. Tanti, ma non certo troppi per la prima monografia su quel pittore e poeta alla corte dei Medici, come recitava il sottotitolo, roscio di capelli – da qui il soprannome – che permeò di sé la Rinascenza fiorentina, e non solo. Una mostra, quella messa in piedi da Carlo Falciani e Antonio Natali appena conclusa a palazzo Strozzi, che ha saputo unire la raffinata eleganza dell’installazione – dal blu intenso delle pareti alle didascalie in forma di volume a narrare le opere – alla bellezza formale del maestro fiorentino allievo del Pontormo.
Sono stati oltre 140mila, alla fine, quelli che hanno staccato il biglietto d’ingresso per visitare Bronzino, a Firenze. Tanti, ma non certo troppi per la prima monografia su quel pittore e poeta alla corte dei Medici, come recitava il sottotitolo, roscio di capelli – da qui il soprannome – che permeò di sé la Rinascenza fiorentina, e non solo. Una mostra, quella messa in piedi da Carlo Falciani e Antonio Natali appena conclusa a palazzo Strozzi, che ha saputo unire la raffinata eleganza dell’installazione – dal blu intenso delle pareti alle didascalie in forma di volume a narrare le opere – alla bellezza formale del maestro fiorentino allievo del Pontormo.
E proprio la pala d’altare con la salita al Calvario di questi, e la dedica in morte fattagli dall’allievo e amico apre la mostra, dopo gli ovali dei Quattro evangelisti a lui qui attribuiti per la prima volta. E se i tratti della Vergine in una Sacra famiglia della gioventù mostrano ancora il tributo di Agnolo di Cosimo al suo maestro, i cromatismi dei 10mila sembrano balzare fuori dalla tela e rivelano già il percorso dell’allievo, pronto a superare il suo mentore. Ma è nella ritrattistica medicea, e in particolare nel magnifico damascato di Eleonora di Toledo, figlia del vicerè di Napoli e sposa a Cosimo I dei Medici, che si riconosce la mano del nostro, come pure nei tratti severi dei coniugi Santiapichi, altre icone del potere della Firenze Medicea. E nel Cristo crocefisso commissionatogli dal banchiere, che il rigore mortuario e formale del cadavere ritratto dal vivo acquista i tratti severi della religio riformata cara al committente, poi mandato ambasciatore in Francia per sfuggire ai rigori dell’inquisizione.
Una bellezza formale a cui non si sottrae neppure il San Bartolomeo scorticato, o la stupenda pala d’altare con la Resurrezione, nella sala dedicata al rapporto col sacro che pure non era caro al pittore di Monticelli, cogli angioli dalle pudende coperte dai pudori controriformisti, ormai dominanti. Di ben altro orizzonte il glande vulvare della Diana Efesina scolpita dal Triboli, a stabilire un principio creativo universale e privo di ogni dogmatismo, proprio del Rinascimento del quale Bronzino fu figlio e faro.